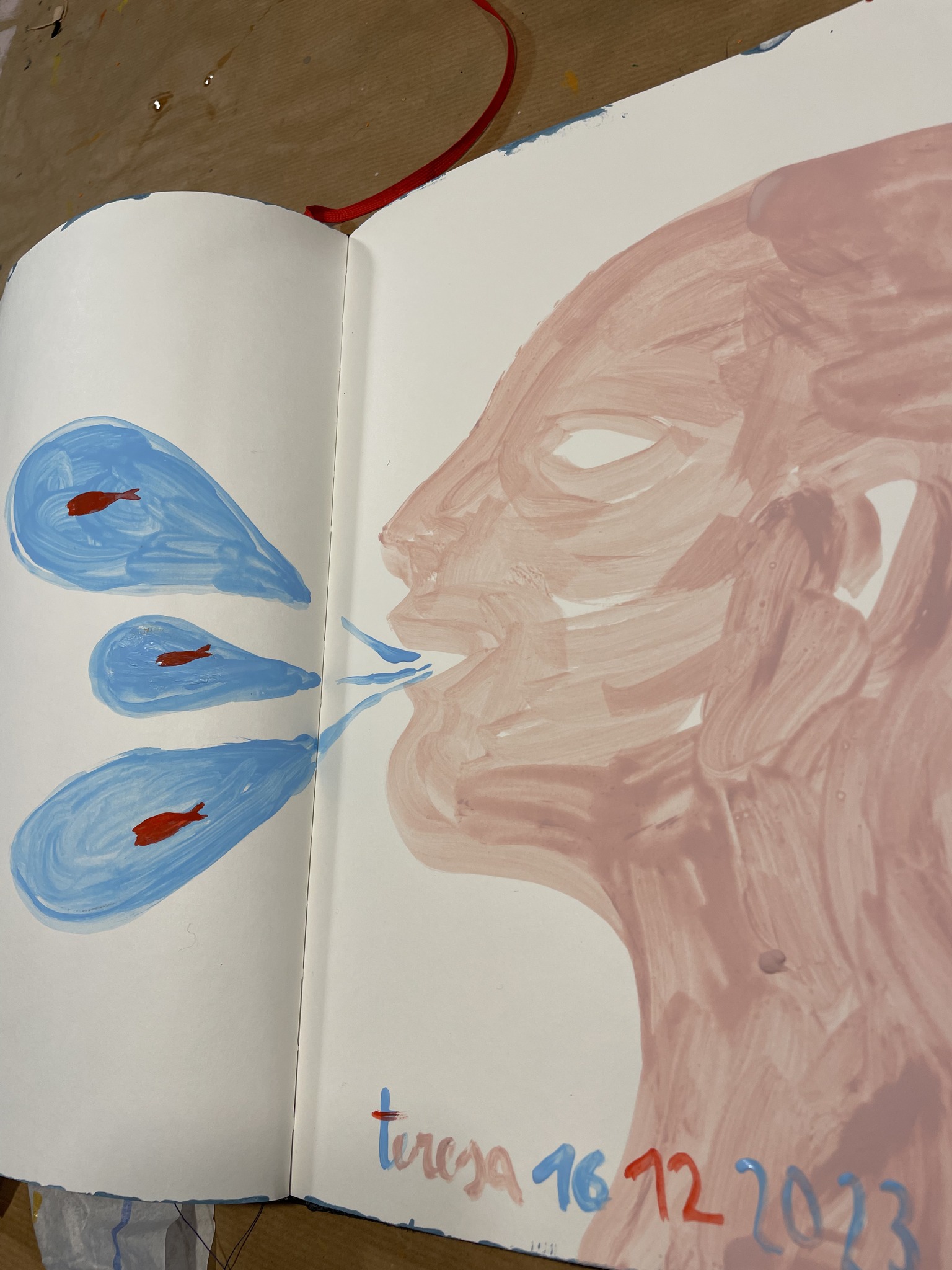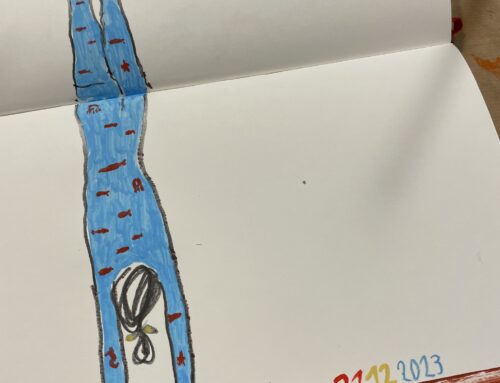La mattina mi sveglia la gente in attesa, seduta in silenzio sul bordo del letto. Caspita, già cinque persone.
Aspettano una storia da me. E quella loro gentile affettuosa mite attesa mi determina a scrollare le coperte da sopra e come un bruco che ha fatto pensiero, abbandonare la crisalide. Per prima cosa mi controllo le caviglie, sono asciutte nessun segno di edema. Poi allungo la mano e prendo Eutirox, la pillola che aspetta il mio incipit per iniziare la sua missione, mediare i messaggi ormonali di oggi. Poi la pipì.
Calze di lana, due maglioni, me ne vado in cucina e mentre bolle l’acqua accendo il portatile. Mi tengo lontana due chilometri dal cellulare, so che qualunque parola mi giunga adesso andrà a orientare la direzione della mia giornata e io non voglio. Quella direzione è mia, è il mio tenero infantile volitivo potere sulla Vita e sul Mondo e io non intendo svenderlo sottocosto così, da stupida. Da scellerata. Appena sveglia il mio potere è immenso. E’ quello che mi viene dalla notte quello che ho ancora addosso. La mollica di pane caldo uscita dalla pancia del sonno, dal silenzio senza capo né coda che restituisce alla parola la sua innocenza. Per nascita, ontologicamente sincera. A condizione di lasciarla in quella sospensione, in quello stare in bilico fra cielo e terra. A condizione di non traumatizzare quel preziosissimo dono del mattino che sbadiglia, mentre il gallo canta per fare a pezzi la foschia la nebbia la pesantezza della rugiada, prendendo il cellulare in mano.
Le parole all’alba sono, per status, per diritto, lo struggente tesoro di carta velina in grado di volare. Non turbiamole, non separiamole, non intossichiamole.
Scrivo nella sospensione che mi regala la notte, nell’assenza di ogni logica terrestre quella sempre occupata e preoccupata, a pesare a fare cernita a discernere; a separare. Nulla deve turbare il miracolo dell’alba, la realtà in bilico, un equilibrio pazzesco, da funambolo, da uno come Petit che cammina sulla fune tra due grattacieli a New York. In questo spazio facendo scudo col mio corpo, sorretta dalla complicità del Tempo che ricomincia daccapo, le parole riacquistano il loro peso, cioè, nessuno, e la loro intenzionalità –mi servono a non cadere giù. A precipitare ma piuttosto, a volare.
E tuttavia una qualità va aggiunta all’aurora, una forza senza la quale questo silenzio resterebbe muto e invece no; che se sta zitto è perché ne ascolti la melodia, una corda di chitarra sulle anche della memoria. Penso alla Concentrazione. Se non avessi l’abitudine alla Meditazione non ce la farei a stare sul pezzo. A restare. Non avere paura cioè, avercela, ma senza mettermi a fare polemica con lei, a giudicarla, ad aizzarmela contro, guardandola di traverso borbottandole uffa. E che certo, che se mi mettessi a fare un polverone per ogni emozione che provo, tantissime, perché durante la giornata come chiatta che drena il fondo melmoso di un canale, ne raccolgo di roba da sotto, e quella montagna di pettegolezzi su me stessa, sicuro va a sabotare qualcosa. Per questo ci si allena.
Il mio coach, Claudio Panarese, Phap Ban, monaco zen della comunità di Plum Village che vive alcuni mesi all’anno a Pescoluse, 80 chilometri da Lecce, non si stanca di ripetere, quando ti accorgi di essere stato rapito da una storia, non questionare non ti rimproverare non farti venire sensi di colpa, quei mattatori, quelle prime donne! Semplicemente, torna. Tre respiri. Non basta, altri tre. Torna ad abitarti. Se non sei felice adesso, ora, tre respiri, mai più accadrà. Perché il momento presente è il solo Reale. Tutto il resto è già andato, tutto il resto non è. Stai qui, un recinto di tre respiri in croce: vedi senti ascolti, sei al centro di un vortice. Sono l’occhio di un ciclone, un centro perfettamente immobile perché non c’è posto nemmeno per un alito di vento. I suoni i colori i sapori i sentimenti che frullano, gli antenati che portano l’acqua attraverso i milioni di canali che ci attraversano, sangue vivo linfa, ossigeno anidride carbonica. Sputo, saliva, lacrima. Siamo una fabbrica che funziona a pieno regime dal giorno della nostra nascita. Miliardi di scambi dentro le officine, miliardi di operai, miliardi di fotogrammi miliardi di sguardi di stringhe vocali. Il tutto che diventa sei, sette rimpianti. Tre crucci. Una disperazione. Un desiderio appuntato in fretta e furia sull’agenda. Una improvvisa determinazione a non buttare questo concentrato di triliardi di tentavi di prove ed errori e di una cosa riuscita bene, dietro le spalle solo perché non mi capisco, tanto meno i miei simili, e tuttavia e proprio per questo, anzi: stacci dentro. Raccoglilo in un abbraccio, quello della scrittura.
Dal cui abbraccio ho l’onore di sciogliermi per prima. Caspita, che fortunata! Sono la mia prima lettrice. Ne ho certezza. Merito di quei cinque in attesa sul bordo del letto. Merito della notte che mette tutte le parole a lavare. Merito della concentrazione che fa stare con quello che c’è con un senso di gratitudine che viene da lontano. Sono una donna misteriosa. I miei natali sono stati rintracciati in una ameba cieca che si crogiolava in un liquido caldo; cosa che le procurava un certo benessere. Tre miliardi di anni fa. Vecchia, sono vecchia da fare schifo.